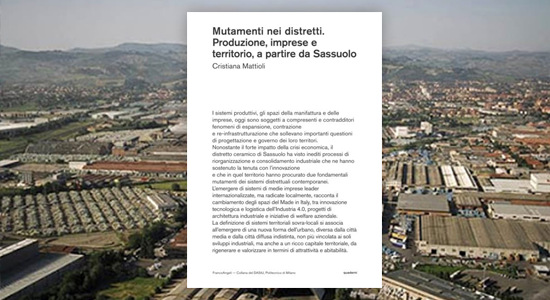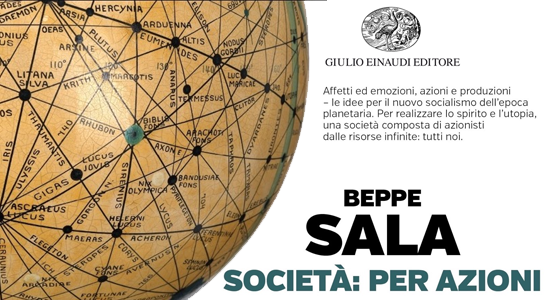L’anticittà
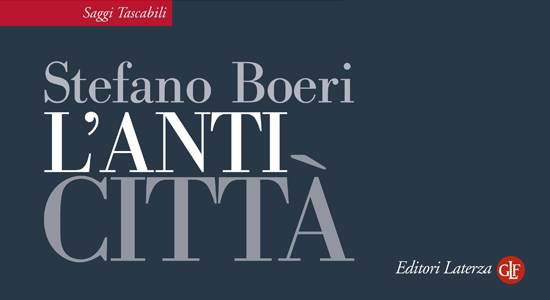
Stefano Boeri
Laterza, Roma‐Bari 2011
L’anticittà, di Stefano Boeri (2011) parte da un presupposto analitico: gli antichi connotati geografici italiani sono stato ritoccati da una grana liquida di materia urbana, che ha invaso pianure e colmato vallate.
Frutto di questo cambiamento è “l’anticittà”, che sembra aver reso irriconoscibile la città italiana ed europea, così come fino a poco tempo fa la conoscevamo.
L’anticittà sta edificando immense città senza confini e sparse nel territorio, estese su aree un tempo destinate all’agricoltura e alla natura, composte da una moltitudine di isole monoculturali e disinteressate al funzionamento dell’organismo geografico e antropologico a cui appartengono.
Il libro, raccoglie una serie di articoli e saggi scritti nel’ultimo decennio e, attorno a questo tema centrale, affronta diverse questioni, tra cui:
- la dispersione territoriale frutto della moltiplicazione di tanti (piccoli) episodi isolati che non dialogano tra di loro (“un brusio di costruzioni improvvise”), che avviene attraverso forme quali, per esempio: le nuove grandi architetture dell’intrattenimento (megastore, multisala, ecc.) che fanno vuoto attorno a sé tramite spianate di parcheggi e infrastrutture; le abitazioni unifamiliari che si insinuano nello spazio contemporaneo in forma pervasiva; i nuovi paesaggi costituiti da grandi scatole che vengono osservate tramite le autostrade;
- l’identità dei luoghi, sempre meno data in modo stabile nel tempo;
- la frustrazione (sociale) e l’omologazione come due principali connotati dell’anticittà;
- la difficoltà di descrivere la natura caotica dei territori e di usare parole appropriate;
- alcune possibili azioni e gli ingredienti principali per una “nuova urbanistica”.
Il testo si interroga, infatti, sui modi per arginare fenomeni di dispersione sociale e territoriale:
- prima di tutto, cercando di rintracciare a una scala ravvicinata, locale, quasi per indizi, i segni della città: identità sociali ricostruite, relazioni tra persone e soggetti;
- recuperando negli intrecci tra sfera urbana, naturale e rurale, nuove possibilità di realizzare luoghi con varietà funzionale e biodiversità: un territorio che non metta sul piedistallo l’uomo ma che si occupi anche della protezione delle specie animali e vegetali e che segua un’etica non antropocentrica;
- rintracciando, infine, nello stesso brusio che rischia di creare omologazione e di distruggere coesione fisica e varietà sociologica, le stesse energie che possono arginare l’anticittà: i suoi antidoti stanno infatti nelle stesse forze psicologiche, economiche e culturali che ogni giorno spingono migliaia di individui diversi a “fare città”, a riunirsi e a costituirsi come comunità, a pensarsi come appartenenti ad un’unica storia.
L’ultimo capitolo affronta il tema di una nuova urbanistica. In esso si afferma che per fare città abbiamo bisogno dello sguardo di un’urbanistica che osservi senza pregiudizi i fenomeni e i
processi che plasmano il territorio. Un’urbanistica dei luoghi che sveli e interpreti il lavoro continuo dei comportamenti sociali sugli spazi. L’urbanistica non deve accontentarsi di essere una sezione amministrativa e tematica della politica, ma deve rappresentare la versione spaziale di tutte le politiche pubbliche. Deve essere simpatetica con le energie che cambiano lo spazio. Deve promuovere forme di interazione e scambio di pratiche ed esperienze dei soggetti e delle comunità, nei e tra i territori. Oggi la principale forma di riequilibrio tra la varietà sociologica e la coesione sociale è legata alle pratiche di lavoro, della produzione, di rischio d’impresa. Alla possibilità, quindi, di costruire occasioni e luoghi di intenso scambio di pratiche ed esperienze creative e di rischio. D’altra parte, questo tipo di urbanistica può nascere solo da un nuovo modello di governo metropolitano: una politica di governo metropolitano che si assuma il rischio di indicare un futuro; una politica di decentramento che affidi a una rete di luoghi deliberativi – veri e propri municipi urbani – il ruolo di mediatori tra politiche metropolitane e istanze dei territori. Inoltre, serve una rete di terminali attivi nei territori, dove i cittadini e le loro comunità di pratiche e di impresa possano trovare risorse, informazioni e spazi, oltre che avere la possibilità di decidere su ambiti di loro pertinenza. In conclusione, serve oggi una grande politica di recupero creativo dei territori delle nostre città, che devono smettere di crescere divorando terra agricola e natura, e cominciare invece ad occuparsi di se stesse, rigenerando e rioccupando quei deserti urbani che possono essere colmati solo riallacciando le istituzioni pubbliche con le energie vitali della società civile. Alla luce di queste considerazioni, molti sono gli aspetti che incrociano i temi propri del Centro Studi PIM quali per esempio: l’analisi delle peculiarità dei contesti locali (nella consapevolezza che la lettura e l’interpretazione di tali peculiarità territoriali può permettere alle politiche urbanisticoterritoriali di trovare le forme più appropriate di “fare città”); la valorizzazione dei soggetti locali (che anche all’interno dei processi di piano sono attivati per il miglior raggiungimento degli obiettivi); la necessità di monitorare le trasformazioni territoriali alle diverse scale; la collaborazione tra Enti Locali come antidoto alla diffusione dell’anticittà e alla dispersione territoriale.
Di questi e altri temi si è parlato durante il seminario di presentazione del libro presso il Centro Studi PIM, avvenuto il 18 ottobre 2011, e sintetizzato in un servizio video disponibile nel Canale YouTube del PIM.