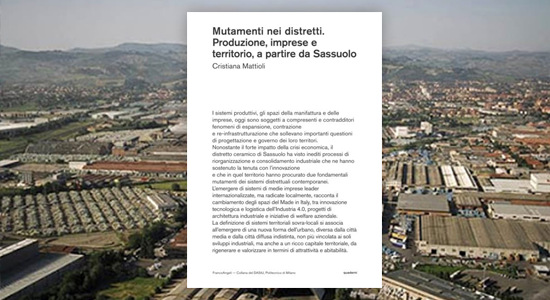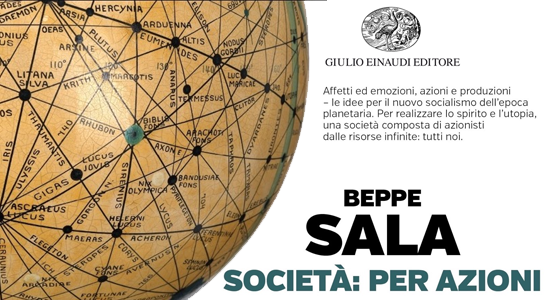Rapporto sulle città. Metropoli attraverso la crisi

Urban@it (a cura di)
Il Mulino, Bologna 2016
pp. 264
Il Rapporto sulle città. Metropoli attraverso la crisi è il frutto del primo anno di lavoro di Urban@it, Centro nazionale di studi per le politiche urbane.
L’interesse per il Rapporto, curato da Marco Cremaschi, è innanzitutto nell’aver scelto uno specifico punto di vista, l’istituzione delle Città metropolitane, in un particolare momento storico in cui il paese cerca di uscire dalla crisi economica, sociale, ma anche politica che ha segnato gli ultimi anni. In tal senso, il Rapporto auspica un maggior interessamento della politica nei confronti delle nostre città, a cominciare proprio dalle città metropolitane, producendo benefici per tutto il paese, come raccomandato peraltro dall’Unione europea e dalle agenzie internazionali.
La città sembra, invece, rimanere sullo sfondo, come fosse il palcoscenico in cui le questioni emergono, faticando ad assumere ruolo di attore centrale di tutte queste vicende, a causa della mancanza di politiche organiche per le città e scarsa attenzione alla ricerca sui temi urbani.
Anche la recente riforma amministrativa appare sempre all’inseguimento dei problemi senza dare l’impressione di poter fornire un contributo decisivo per la loro risoluzione.
Come sottolineato da Alessandro Balducci nella Presentazione, il Rapporto sulle città costituisce un primo contributo che Urban@it offre alla costruzione di politiche per le città italiane, con l’obiettivo di:
- sollecitare e supportare governo e parlamento nell’indirizzare verso le città una rinnovata attenzione progettuale e risorse adeguate, così come indicato da parte della Commissione europea;
- mettere in rete le migliori esperienze di studio e le migliori proposte sui temi delle politiche urbane sviluppate nei centri di ricerca del paese, in grado di contribuire alla costruzione di linee di indirizzo per politiche veramente nazionali;
- costruire occasioni di scambio e di formazione che accorcino le distanze tra conoscenza e azione e tra ricerca, istituzioni e società.
Nel Cap. I “Conoscenze. Le trasformazioni delle città italiane” si sottolinea come le città europee siano di medie dimensioni e complementari al territorio che le circonda, eredità del medioevo. In Italia, seppur con caratteristiche policentriche che non trovano riscontro in altri contesti europei, ci troviamo di fronte all’emergere di vere e propri regioni urbane, nelle quali è sempre più difficile rintracciare le caratteristiche delle città tradizionali, mentre si manifestano nuove forme di urbanità e nuove domande di cittadinanza. Soprattutto, si emergono problematiche in parte diverse rispetto al passato, come il consumo di suolo, la crisi dell’edilizia e del settore immobiliare, la mobilità esplosa, l’inquinamento, i conflitti e le crescenti diseguaglianze sociali, il ritardo infrastrutturale, l’invecchiamento e la rarefazione della rete dei servizi.
La città appare trasfigurata, diversa dal passato, sfuggente e incomprensibile se si pretende di continuare a guardarla con i canoni tradizionali, a lungo in secondo piano nella discussione pubblica.
L’ipotesi che, invece, il Rapporto di Urban@it sostiene è che le città avrebbero la capacità di dare risposte ai problemi urbani e, più in generale, del sistema Italia. Tuttavia, le città faticano a entrare nell’agenda politica del paese e l’unica sostanziale riforma finora realizzata, con grande difficoltà, riguarda le città metropolitane, mentre, a sua volta, la ricerca universitaria, pur penalizzato dalla crisi, mostra alcuni interessanti temi per l’agenda pubblica, tratti da tre grandi progetti in corso finanziati dal Ministero: l’urbanizzazione metropolitana, la diffusione dei migranti nei comuni minori e il riciclo come orizzonte generale delle politiche territoriali.
Più critico appare, invece, l’uso delle conoscenze prodotte dalla ricerca da parte dei policy makers, in particolare in tema di sprawl, declino urbano e riduzione della taglia di alcune città sottoposte a processi di shrinking, tutti temi che pongono un sostanziale problema di riuso dell’esistente e di nuovi approcci anche dal punto di vista tecnico.
Questo intreccio tra scale e problemi rende manifesto che questi fenomeni non sono contenibili nei confini amministrativi abituali e trascendono la capacità di azione delle amministrazioni locali, imponendo nuove forme di scambio e cooperazione.
In tale ottica, anche se gli effetti della riforma metropolitana si esplicheranno nel prossimo futuro, già fin d`ora si riconosce un processo di differenziazione degli esiti, con situazioni alquanto eterogenee createsi con la coincidenza di provincia e città metropolitana.
La complessa attuazione della riforma delle Città metropolitane e il carattere ancora interlocutorio delle soluzioni individuate sono messi a confronto, nel Cap. II “Innovazioni. La riforma del governo locale”, con il processo di riforma in atto in Francia, dove le metropoli hanno competenze esclusive su materie quali lo sviluppo economico, la pianificazione del suolo, della mobilità e dei trasporti pubblici, la politica sociale e degli alloggi, la gestione di servizi di interesse collettivo.
Al momento, in Italia uno dei principali contributi della riforma metropolitana è dato dall’interesse per la sperimentazione del Piano strategico metropolitano che, pur nella variabilità dei contenuti e delle formule, dovrà affrontare localmente le priorità dell’Agenda nazionale, a partire da trasporti e mobilità.
La stessa riforma sembra solo in parte capace di rispondere alle recenti problematiche dell’urbano. Essa ammette la possibilità di superare i vecchi confini amministrativi e di sperimentare nuove politiche e visioni strategiche per tali contesti, ma non fornisce un quadro chiaro per la riorganizzazione delle politiche e dei livelli di governo territoriale, che necessiterebbero, invece, di una maggior cooperazione tra le amministrazioni locali attuando gli indirizzi provenienti dalla Unione Europea che spingono a una nuova attenzione verso le dinamiche metropolitane.
Il Rapporto auspica, quindi, un cambio deciso di impostazione, pur mantenendo una forma di cooperazione tra governo nazionale e locale per costruire uno scenario condiviso.
Diventa allora importante (Cap. III “Risorse. Fondi comunitari per le città metropolitane”) la verifica di strumenti e risorse a disposizione della città, principalmente nel quadro delle politiche di programmazione dei fondi strutturali, e in particolare del nuovo Programma operativo nazionale 2014-2020 dedicato alle città metropolitane (Ponmetro), che identifica tre sfide principali: economica, ambientale e il contrasto al disagio e alla povertà abitativa.
Il Ponmetro, prendendo le mosse sia dall’identificazione della centralità delle città nella definizione di processi di uscita dalla crisi socio-economica, sia dal riconoscimento della profonda diversità di condizioni di partenza dei contesti metropolitani, sconta la fase incerta delle politiche urbane italiane, storicamente prive di un indirizzo coerente, e il delicato momento di attuazione della riforma delle città metropolitane.
Il tema delle politiche urbane arriva a compimento di un lungo periodo di sperimentazione e gestazione di iniziative politiche da parte della Commissione e del Parlamento europeo. Oggi, le aspettative appaiono cresciute, con le città elevate al rango di motore economico della ripresa nei recenti documenti della Unione Europea e, in paesi come Francia, Germania, Olanda, Gran Bretagna, la politica della città è da tempo al centro delle scelte di sviluppo e di coesione e le politiche urbane sono parte importante delle strategie nazionali.
Più recentemente, la strategia Europa 2020 e l’enfasi su crescita, creazione di lavoro e innovazione, contribuiscono a riorientare in parte le politiche urbane sul cambiamento climatico, l’innovazione sociale, quella tecnologica e le politiche energetiche.
Oggi, secondo gli autori, uno sforzo importante è stato fatto per individuare nuove risorse e nuovi modi di fare le politiche urbane, permettendo, in particolare dove entrano in gioco risorse inedite e importanti, come i fondi strutturali europei o le politiche transfrontaliere, processi di apprendimento e crescita inediti, che mobilitano attori e iniziative trasversali alle scale e alle istituzioni.
Nel successivo Cap. IV “Modelli. Le Agende urbane nazionali ed europea” si evidenzia la varietà dei paesi che hanno adottato e stanno realizzando politiche urbane e il ruolo svolto da organismi internazionali nel diffondere modelli e far circolare esempi e conoscenze.
La riflessione sulle politiche nazionali per le città è segnata dal confronto a distanza tra Stati Uniti ed Europa e sulla riflessione sugli effetti locali delle politiche urbane nazionali. Comune a queste esperienze è un modello classico che accoppia marginalità sociale e degrado urbano, mentre in altri paesi, pur con problemi e priorità differenti, tendono spesso ad affermarsi gli stessi modelli di intervento.
Nella fase più recente, emerge la differenza fra modelli di intervento europei, di rigenerazione fisica ed economica, e quelli dei paesi di recente urbanizzazione che programmano i nuovi assetti produttivi attraverso l’espansione spesso modulare e ripetitiva della rete di città.
A sua volta, lo sviluppo urbano sostenibile assume declinazioni diverse a seconda che si associ alla produzione, alle nuove tecnologie, all’ambiente o alle conseguenze sociali, mentre si sottolinea il carattere innovativo e sperimentale di molte esperienze, talvolta di minor peso o geograficamente marginali, che interessano il coordinamento tra attori, l’integrazione funzionale, la partecipazione delle comunità. Infine, costituiscono parte integrante del Rapporto i Background Papers che numerosi autori hanno prodotto per Urban@it e che sono pubblicati in insieme al documento di sintesi del Rapporto.
Anche se questo primo Rapporto disegna una mappa ancora parziale, che verrà completata successivamente, la prima conclusione che possiamo trarre è che la storia italiana si riassume in una dialettica non sempre costruttiva tra nostalgie centraliste e ideologie localiste che hanno sostanzialmente esaurito le intenzioni di riforma. È una situazione che rischia di farci perdere, o quantomeno di lasciare deperire, la grande risorsa storica data dal l’armatura urbana del paese. La città italiana, così come quella europea, è stata il motore dell’economia, della società, della politica e della democrazia, senza che a questo corrispondesse un vero e proprio processo di innovazione a carattere nazionale. A sua volta, l’Unione Europea preme perché le città mettano in opera con l’Agenda urbana le diverse iniziative orientate al raggiungimento degli obiettivi generali. Alle radice dell’Agenda urbana europea sta la convinzione che l’innovazione tecnologica possa cambiare la natura dell’economia del continente e far ripartire i sistemi produttivi. Si tratta di uno strumento di innovazione, dal carattere fortemente urbano, uno degli intrecci possibili tra autorità e autonomia nelle attuali condizioni. Proprio per questo occorre saper ragionare tra passato e futuro, salvaguardare la città e il suo ruolo in un contesto rinnovato, nel quale la città stessa è profondamente cambiata e va guardata, amministrata e trasformata in modo nuovo. E qui, come evidenzia il Rapporto, emerge innanzitutto, la necessità di coordinamento delle diverse politiche settoriali e dei diversi attori pubblici e privati che operano su medesimi ambiti, la mancanza di una regia nazionale e la sostanziale inattività del Cipu e i rischi ai quali queste incertezze espongono iniziative recenti come la riforma metropolitana e il Programma operativo nazionale per le Città metropolitane del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 (Ponmetro).
A livello centrale ci sarebbe molto da imparare dalle città, e l’innovazione prodotta in determinati luoghi potrebbe essere riprodotta altrove. Anche da questa diversa prospettiva le città meritano attenzione, per i tentativi intrapresi e le soluzioni innovative che hanno messo in campo in questi anni, che contengono suggerimenti preziosi per affrontare le sfide del rinnovamento complessivo del paese.
Se non è scontato che cosa sia oggi la città in Italia, né è scontato che cosa potrebbe essere e che cosa effettivamente essa diventerà, è evidente che solo se le prestiamo l’attenzione dovuta essa riuscirà a contribuire in maniera significativa al futuro del paese.
Autori
Urban@it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane è un’associazione che si è costituito nel 2014 a Bologna in forma di rete di soggetti attivi sui temi delle politiche urbane. È promossa da università (Università di Bologna, Politecnico di Milano, IUAV di Venezia, Università di Firenze, Università Roma Tre, Università Federico II di Napoli, Politecnico di Bari, Università La Sapienza di Roma, Università Milano Bicocca), e da altri tre soggetti (ANCI, Società Italiana degli Urbanisti e Laboratorio Urbano di Bologna).
Obiettivo primario di Urban@it è costruire reti, alimentarle e allargarle, contribuendo a far uscire i singoli dipartimenti universitari e i centri di ricerca da una relazione spesso limitata al loro contesto regionale. Nello stesso tempo si propone di aiutare chi si occupa di politiche nazionali ad avvicinarsi alla specificità dei contesti locali per valorizzare il contributo che le politiche urbane possono dare alla soluzione dei problemi del paese, dialogando con la ricerca sia in sede di policy design che di valutazione dei risultati.
Il Centro si rivolge anche ai protagonisti fondamentali della vita della città (mondo del lavoro e dell’impresa, al sistema del credito, al terzo settore e alla cittadinanza attiva) per contribuire a metterli in relazione con le istituzioni e la ricerca nell’individuazione dei problemi e delle possibili risposte..